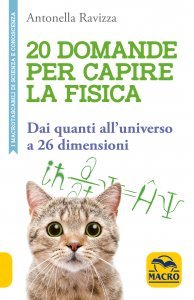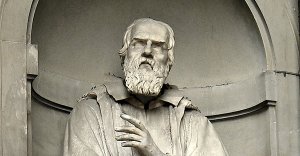Il vuoto quantistico - La storia del vuoto dalla filosofia alla scienza moderna
Scienza e Fisica Quantistica
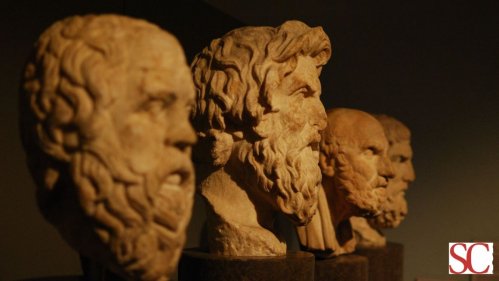
Scienza e Fisica Quantistica

La storia del concetto di vuoto attraversa secoli e discipline, toccando sia la filosofia che la fisica, ed è ricca di dibattiti e trasformazioni concettuali. Ripercorriamo in questo articolo l'idea di vuoto nella storia della filosofia.
Varutti Guerrino - 18/02/2025
Filosofia antica e il vuoto
Presocratici e il problema dell’essere
I filosofi presocratici furono i primi a confrontarsi con il concetto di vuoto, legandolo alla natura dell’essere.
- Parmenide (V secolo a.C.) sosteneva che il vuoto non poteva esistere perché "il nulla non è", rifiutando l'idea di uno spazio vuoto. Secondo lui, l'universo era un continuo pieno, senza interruzioni.
- Democrito e Leucippo, invece, introdussero l'idea del vuoto come componente essenziale della loro teoria atomista. Secondo questi filosofi, l'universo era costituito da atomi (indivisibili e pieni) che si muovevano in un vuoto infinito. Il vuoto era quindi necessario per spiegare il movimento e il cambiamento
Aristotele e la critica del vuoto
Aristotele (IV secolo a.C.) rifiutò l’esistenza del vuoto, sostenendo che la natura "aborrisce il vuoto" (horror vacui). Per lui, il vuoto era una contraddizione logica, poiché uno spazio senza materia non avrebbe potuto permettere il movimento o la definizione della velocità.
Medioevo e prime nozioni di vuoto
Durante il Medioevo, il concetto di vuoto fu discusso soprattutto nel contesto teologico e filosofico, spesso influenzato dal pensiero aristotelico. Tommaso d’Aquino riprese le argomentazioni di Aristotele, affermando che il vuoto non poteva esistere perché era contrario all'ordine naturale del mondo creato da Dio. Nonostante ciò, alcuni filosofi medievali, come Giovanni Buridano e Niccolò d’Oresme, iniziarono a mettere in discussione il dogma aristotelico, aprendo il dibattito sull'esistenza di uno spazio privo di materia.
Rinascimento e la rivoluzione scientifica
Il Rinascimento e la rivoluzione scientifica segnarono un cambio di paradigma. Evangelista Torricelli, nel XVII secolo, dimostrò sperimentalmente l'esistenza del vuoto. Con il suo esperimento del tubo di mercurio (1643), creò uno spazio vuoto sopra la colonna di mercurio, dimostrando che il vuoto non era solo una costruzione teorica. Blaise Pascal ampliò gli esperimenti di Torricelli, dimostrando che la pressione atmosferica variava con l'altitudine, confermando ulteriormente l'esistenza del vuoto e il grande genio italano di Galileo Galilei criticò l’idea aristotelica del horror vacui, sostenendo che il vuoto potesse esistere e che non ci fosse alcun principio naturale che lo vietasse.
L'età moderna: vuoto e meccanica classica
Con Isaac Newton e la nascita della meccanica classica, il vuoto assunse un nuovo significato. Newton immaginava il vuoto come uno "spazio assoluto" in cui i corpi si muovevano secondo le leggi della meccanica. Il vuoto non era più visto come un nulla assoluto, ma come uno spazio privo di materia, utile per descrivere il moto dei corpi.
Tuttavia, il concetto di vuoto rimase dibattuto. Cartesio, ad esempio, rifiutava il vuoto e proponeva che tutto fosse riempito da una "materia sottile" o "etere".
L'etere e l'elettromagnetismo
Nel XIX secolo, l'idea di vuoto fu profondamente legata alla teoria dell’etere. L’etere era considerato un medium attraverso cui si propagavano le onde luminose ed elettromagnetiche, analogamente al suono che si propaga nell’aria. Tuttavia gli esperimenti di Michelson e Morley (1887) misero in discussione l'esistenza dell’etere, aprendo la strada a nuove teorie.
Il XX secolo rivoluzionò completamente la comprensione del vuoto, grazie alla teoria della relatività e alla meccanica quantistica. Con la teoria della relatività generale, Einstein ridefinì lo spazio vuoto. Il vuoto non era più uno spazio assoluto immutabile, ma una struttura dinamica influenzata dalla presenza di massa ed energia. Lo spazio-tempo poteva curvarsi e deformarsi, rendendo il concetto di vuoto ancora più complesso.
La meccanica quantistica poi introdusse l'idea che il vuoto non fosse realmente vuoto, ma un mare di fluttuazioni quantistiche. Anche nello stato di energia più basso, il vuoto possiede una "energia del punto zero" e può generare particelle e antiparticelle per brevi istanti (effetto delle fluttuazioni quantistiche).
Con il modello standard della fisica delle particelle, il vuoto assunse un ruolo attivo. Il campo di Higgs, responsabile della massa delle particelle, permea tutto lo spazio, suggerendo che il vuoto non è un nulla, ma una struttura sottostante.
Il vuoto nel contesto cosmologico
Nel contesto cosmologico, il vuoto gioca un ruolo fondamentale.
- Energia oscura:
L'accelerazione dell'universo è attribuita a un’energia associata al vuoto, chiamata energia oscura. Questo suggerisce che il vuoto abbia proprietà che influenzano la dinamica dell’universo su larga scala.
- Inflazione cosmica:
Teorie sull'universo primordiale implicano che il vuoto abbia subito transizioni di fase, generando l’espansione esponenziale dell'universo.
Il vuoto dunque ha attraversato un lungo cammino concettuale, da una negazione totale nella filosofia antica all’essere visto come un medium dinamico e ricco di proprietà nella fisica moderna. Il vuoto non è più inteso come "assenza di tutto", ma come una realtà complessa, piena di energia e attività, che sfida le nostre intuizioni più profonde sul nulla e l’essere.
Guerrino Varutti